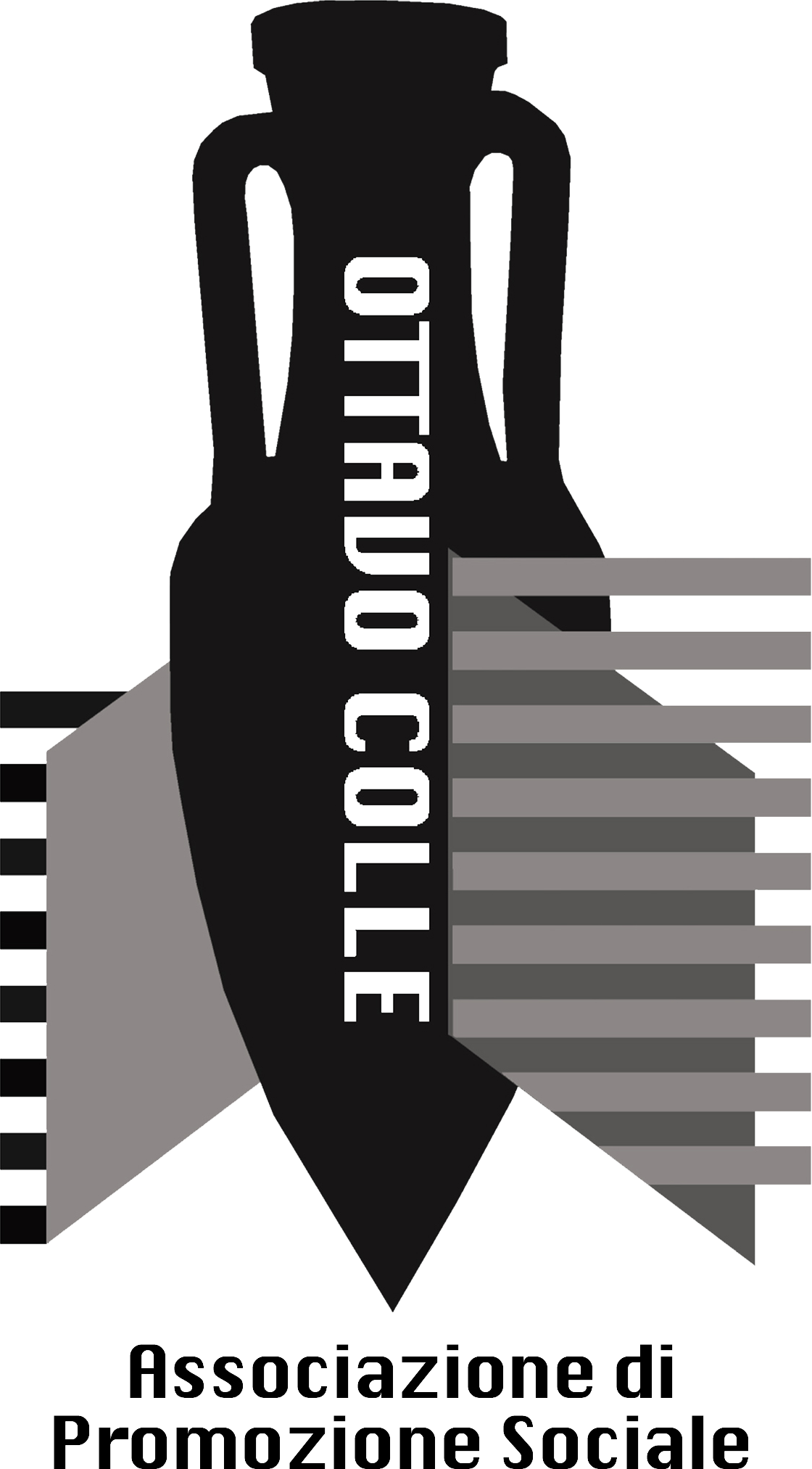SET, “Sud Europa contro la turistificazione”, crea una rete di città contro la turistificazione e le sue conseguenze. Con qualche contraddizione
Un recente manifesto unisce una rete di città contro l’uso “turistico” dei luoghi, e introduce importanti nuovi argomenti al dibattito sulla gentrification. Purtroppo, però, in una visione “nimby”, e con alcune contraddizioni
I quartieri una volta costruiti, di regola, cambiano lentamente nel corso degli anni… i residenti si lamentano del fatto che il quartiere sia cambiato. Eppure in realtà fisicamente è cambiato davvero poco. I sentimenti delle persone a riguardo, piuttosto, sono cambiati. Il quartiere mostra una strana incapacità di aggiornarsi, rianimarsi, ripararsi o essere ricercato come luogo, per scelta, da una nuova generazione. Ciò che è morto in realtà era morto dalla nascita, ma nessuno se ne è accorto fino a quando il cadavere non cominciò a puzzare (Jane Jacobs, The Death and Life of Great American Cities, 1961).

Jane Jacobs.
Mi è di recente capitato di leggere della nascita di una rete di città del Sud Europa unite contro la “turistificazione”. Si tratta di “Set, Sud Europa contro la turistificazione”. Il manifesto mette insieme città come Venezia, Valencia, Siviglia, Palma, Pamplona, Lisbona, Malta, Malaga, Madrid, Girona, Donostia/San Sebastian, Canarie, Camp de Terragona e Barcellona, per combattere i mali del turismo. I presupposti da cui nasce sono a prima vista condivisibili, ma a mio parere hanno un limite nell’individuare il problema che vogliono affrontare. Vediamoli insieme.
- Prima di tutto, l’aumento della precarizzazione del diritto all’alloggio, conseguenza di processi di gentrificazione legata alla speculazione immobiliare per fini turistici.
- Quindi l’aumento del costo della vita e la trasformazione delle attività commerciali di prossimità in attività turistiche, che non rispondono più alle esigenze della popolazione locale.
- Poi, la massificazione dei luoghi, che snatura la vita quotidiana degli abitanti e, soprattutto nei centri più piccoli, la saturazione del sistema di trasporti locale.
- La dipendenza dell’economia locale dal settore turistico che l’espone ad una maggiore fragilità e precarizza le condizioni di lavoro, spesso con salari più bassi, esternalizzazioni, lavoro in nero, stragionalità.
- Inquinamento ambientale e sfruttamento di risorse e territorio, anche per la costruzione di infrastrutture che non servono la popolazione, ma il turismo. Infine, la banalizzazione del territorio che diviene una sorta di parco tematico.
Fin qui tutto bene, se non fosse che il problema viene inquadrato localmente, mi viene da dire in un’ottica nimby – Not in my back yard, quando la questione dell’impatto del turismo di massa è un problema globale attraversato da traiettorie che dovrebbero colpire in primo luogo le amministrazioni locali e centrali, e non il consumatore-turista che consuma ciò che qualcun altro ha confezionato, nel piatto, per lui.
Infatti, un recente studio pubblicato dall’Università di Sidney sul crescente impatto ambientale del turismo di massa, fenomeno in espansione grazie soprattutto al crescente potere d’acquisto dei lavoratori della classe media in Cina ed in India e allo sviluppo del trasporto aereo, indica che l’impronta di carbonio del settore è 4 volte più alta di quanto ci si aspettasse, e pari ad oltre il doppio di quella dell’intero commercio internazionale. Si tratta dell’8 per cento del totale delle emissioni di gas serra in un anno. Anche solo questo dato di fatto, al di là dei problemi individuati da Net, dovrebbe farci ragionare sull’impatto non solo climatico, ma anche sociale e culturale, del turismo di massa e sul fatto che sia urgente e necessario trovare delle regole globali. I ricercatori australiani suggeriscono, ad esempio, di ridurre gli spostamenti internazionali aumentando i costi dei voli con una sorta di Carbon Tax.
“Se volassi da Melbourne nel Regno Unito e ritorno, dovrei pagare almeno 425 dollari in più per compensare le mie emissioni – ha commentato Manfred Lenzen, uno dei ricercatori dell’Università di Sydney coinvolti nella ricerca – per un viaggio di andata e ritorno tra Sydney e Brisbane [circa 900 chilometri, poco meno della distanza in aereo tra Reggio Calabria e Milano, NdR], circa 45 dollari in più”. In alternativa si dovrebbe limitare l’accesso alle località più esotiche e a rischio, come le isole dell’Oceano Indiano che, oltre ad essere minacciate dall’innalzamento del livello del mare, hanno un’impronta di carbonio prodotta all’80 per cento dal turismo o, infine, obbligare gli operatori del settore, che ormai vale oltre 3000 miliardi di dollari all’anno, a piantare alberi in proporzione alla Co2 prodotta. La cosa interessante, però, è che, al di là dell’impatto dei voli aerei, proprio molti degli elementi individuati da Net contribuiscono in maniera determinate all’enorme emissione di Co2 prodotta dal turismo. La questione è quindi avere una visione globale di un problema locale, che a Net sembra ancora mancare. Tutte le iniziative locali sono bene accette, come quella di Net, occorre affrontare però il problema nel suo complesso. Altrimenti si rischia, in questo modo, di divenire essere poco più di un pretestuoso esercizio di campanilismo che non affronta e non risolve i veri problemi. Il turismo non è il diavolo ed è un fondamentale volano economico; non solo, nella sua versione di turismo locale a km 0 come avviene in alcune città come Roma, dove è attiva l’associazione culturale Ottavo Colle, è addirittura una forma di resistenza alla gentrification nelle periferie. Anche perché è da intenderci sul vocabolo, come ho cercato di fare nella prima ricerca in italiano su questo fenomeno. Perché se tutto è gentrification, ovvero allontanamento e sostituzione violenta delle classi originarie di un luogo in virtù dell’arrivo di una classe socialmente ed economicamente “superiore”, allora nulla è gentrification.
Occorre infatti agire globalmente e favorire un turismo a basso impatto ambientale, possibilmente a chilometro zero, o utilizzando mezzi di trasporto sostenibili, a partire dal treno e dalla bicicletta e anche a piedi. Un turismo più slow e consapevole, che guarda alla sua sostenibilità sul territorio, che sta sempre più prendendo piede. Occorre appoggiare questa trasformazione. Chiudere le città serve a poco o a nulla. Servono scelte politiche lungimiranti e il cambiamento della cultura del turismo in un mondo che diventa sempre più piccolo e globale in cui localismi non hanno senso.
Non città e luoghi a numero chiuso, come Venezia o, a Roma, la Fontana di Trevi, o, in Spagna Ibizia e Mallorca ma una nuova sensibilità per chi visita i luoghi affinché non li usi, ma vi appartenga. Del resto a chi appartengono le città? Le città non solo abitazioni, monumenti, piazze e strade. Le città sono donne e uomini, storie e immaginari. Certamente non possono qui appartenere agli speculatori che sfruttano il valore dei luoghi al solo fine di accrescere il capitale. Di chi sono, dunque le città. Di chi le costruisce, di chi le abita o di chi le rivendica come luogo proprio? Chi, però, tra quelli che le hanno costruite è ancora vivo, anche solo generazionalmente, ha titolo per rivendicarne il possesso? Chi, di chi le abita, può rivendicarne a buon diritto il jus soli? Chi, infine, tra coloro che ne rivendicano, demagogicamente il possesso, è giustificato a farlo? Jane Jacobs, che ho voluto citare in preambolo, risponde a chiare lettere che nessuno di questi pretendenti è legittimato a rivendicare alcunché se non ha un’effettiva consapevolezza del luogo che abita ed agisce. Il senso del luogo è comunità e cultura. Ed è anche cura del “simbolismo urbano”. Quest’ultimo aspetto è affrontato dall’arte urbana, dalle sue declinazioni in opere site specific o community specific come ad esempio il progetto M.U.R.O. nel quartiere Quadraro a Roma. Opere murarie ispirate al rastrellamento da parte dei nazifascisti del 17 aprile 1944 avvenuto nel quartiere, medaglia d’oro della resistenza. Facendo una confusione sui termini e sulle dinamiche, in queste strade isolati cittadini hanno fatto atti di vandalismo sulle opere e sugli artisti, individuati come bersaglio di una gentrification che al Quadraro non si vede proprio nemmeno in lontananza. A tale proposito è utile leggere il saggio pubblicato su “Urban Studies” che mette in relazione gentrification e impatto dell’industria culturale nei luoghi.

Le città coinvolte nel manifesto di SET.
La ricerca esplora questa connessione e lo fa esaminando, con l’ausilio dei codici postali in 30 grandi aree metropolitane, una popolazione di oltre 2 milioni di persone. Lo studio ha osservato gli anni tra il 2000 e il 2013, un periodo di intensa gentrificazione in alcune città.Considera gli effetti dell’industria legata all’arte – inclusi artisti indipendenti, gallerie d’arte, scuole di belle arti, musei e compagnie di arti dello spettacolo – e le arti commerciali, come le industrie del cinema, della musica e del design. Nel loro studio, i ricercatori – Carl Grodach della Monash University in Australia, Nicole Foster dell’Università del West England e James Murdoch dell’Università del Texas– hanno parlato di Zip Gentrification dividendo i quartieri in cinque categorie: quartieri benestanti, quartieri già gentrificati, quartieri in via di gentrificazione, quartieri potenziali per la gentrificazione, quartieri a nessun potenziale per la gentrificazione. Un codice postale nel loro studio “conta” come “gentrificante” se, tra il 2000 e il 2013, ha registrato un aumento della percentuale di giovani sopra i 25 anni con un diploma di laurea, con una disponibilità economica maggiore alla media, come nonché se nel quartiere si è verificato un aumento del valore mediano delle abitazioni. Ebbene lo studio ha dimostrato che l’industria legata all’arte che già risiedeva nei quartieri benestanti è rimasta li senza spostarsi in aree della città in via di gentrification. Quindi il ciclo delle “città creative” ipotizzato da Richard Florida nella metà degli anni 2000 che vedeva gli artisti come pionieri della gentrification è stato smentito dai dati statistici. Ciò detto non si può affermare che l’arte urbana non possa essere uno dei tasselli della gentrification ma più come effetto, che come causa scatenante. Se pensiamo al centro storico di Roma, Campo dè Fiori, Trastevere, Monti invaso dal turismo di massa, notiamo una presenza davvero minoritaria di opere di street e urban art.
Se non c’è cura delle narrazioni dei luoghi, non c’è senso del luogo e non c’è forma di resistenza o resilienza alla speculazione. Il luogo diventa un contenitore di umanità, un “non valore” se non immobiliare e speculativo. Jane Jacobs si è battuta tutto contro la speculazione cercando di restituire comunità, storia e senso ai luoghi per renderli “resistenti” e resilienti alle sue lusinghe. La Jacobs si batteva contro i grandi immobiliaristi che, acquistando lotti e premendo per infrastrutture invasive, miravano ad aumentare il valore delle case e dei terreni per espellere gli abitanti “originari” e sostituirli con affittuari e proprietari più facoltosi allo scopo di aumentare il valore dei luoghi e guadagnarci con l’inevitabile disfacimento della comunità e la perdita della sua storia e del suo valore culturale, che sono un patrimonio comune dell’umanità. Per mantenere viva la sua lotta per la memoria ed il presente dei luoghi, oggi, si svolgono, in tutto il mondo e dall’anno della sua morte 12 anni fa, i “Jane Jacobs walks”. Passeggiate, ma anche azioni di testimonianza attiva per fare in modo che i quartieri non perdano il loro valore storico, culturale e sociale e riescano a tramandarlo nelle generazioni. A queste passeggiate partecipano turisti locali, che scoprono elementi del loro territorio che non conoscevano, oppure li testimoniano, e turisti “stranieri”, magari provenienti dall’estero o semplicemente dai quartieri circostanti, curiosi di sapere cosa c’è intorno al loro orto concluso. Se questi ultimi decidono di vivere in questo quartiere è perché trovano, valore, non solo immobiliare, in quello che apprendono e in cui si riconoscono. Il valore è infatti immateriale. È fatto di storia, di cultura ed umanità. Non certo di speculazione immobiliare, quella viene dopo, e saranno essi stessi ad opporsi. Jane Jacobs, però, non era contro il cambiamento. Come scriveva infatti, “ciò che è morto in realtà è morto fin dalla nascita, ma nessuno se ne è accorto fino a quando il cadavere non cominciò a puzzare”. La gentrification colpisce le comunità deboli, quelle chiuse, non in grado di rigenerarsi aprendosi a nuove idee e a nuovi stimoli. Le comunità, se vogliono sopravvivere, devono aprirsi e non chiudersi. Devono accompagnare il proprio cambiamento, non restare immutabili. Devono trovare il modo di mantenere viva e tramandare nel cambiamento la propria narrazione se non vogliono sparire. Il turismo etico, l’incontro con l’altro, sono tutto questo. Ed il lavoro culturale nel turismo o in altre forme, è un lavoro e come tale ha un valore, un costo ed un ovvio ritorno economico per i lavoratori che impiega. Tutto il resto è retorica, o come recita una scritta in un’aula universitaria a Roma “è fare la rivoluzione anticapitalista, seduti comodamente sul divano di nonna”.